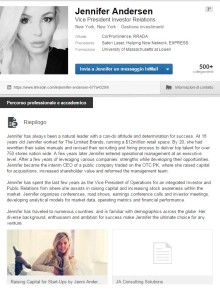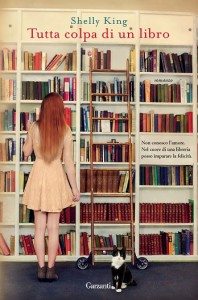Negli ultimi giorni un’immagine tra le più condivise su LinkedIn è quella qui sopra. Il messaggio è semplice: LinkedIn è un social network legato al mondo del lavoro, quindi deve essere usato in modo professionale, senza lasciarsi andare a “problemi di matematica”, “che cosa mangerete a pranzo”, oltre che ai selfie.
Richiesta più che legittima, si dirà. Perché lordare i contenuti seri e certificati che gli utenti osservanti postano con cura e passione con osservazioni che non hanno nulla a che fare con il mondo del lavoro?
A pensarci appena più attentamente, però, mi pare che la richiesta sia non solo ingiustificata, ma inutile, e addirittura dannosa. Oltre che perbenista. Ecco perché.
1) Esistono delle policy esplicite, normalmente declinate al negativo, che sanciscono le libertà degli utenti sui social network. Ossia, per semplicità questi regolamenti dicono ciò che non si può dire o pubblicare. Se scrivo insulti razziali su Facebook, il mio post sarà rimosso. Se pubblico un video su YouTube con umani nudi, questo viene oscurato. Se uso turpiloqui in una recensione su Amazon questa non verrà pubblicata.
Che ciò porti al limite del ridicolo è quasi inevitabile: in una vecchia policy di Facebook le categorie proibite per le immagini erano “Sesso e Nudità”, “Uso illegale di droghe”, “Furto, vandalismo e frodi”, “Messaggi d’odio”, “Immagini forti”, “Blocco degli IP”, “Automutilazione”, “Bullismo e assalto”, “Minacce credibili”. Da cui, ad esempio, il recente caso di censura de L’origine del mondo di Courbet. Ma sarebbe interessante conoscere i criteri per la classificazione delle “immagini forti”, dei “messaggi d’odio” e delle “minacce credibili”.
Tuttavia, sino a presente nessuno può impedire a qualcuno di pubblicare su LinkedIn foto del proprio cane, come ben chiaro se si leggono le ”Attività consentite” e “Attività non consentite” di LinkedIn. Nella lunga lista di attività che l’utente conferma di non voler svolgere all’interno del network è incluso tutto ciò che gli utenti normalmente fanno (incluse le promozioni di schemi piramidali di networking, di attività legate alla prostituzione, lo spam, il phishing e altre amenità).
2) Detto di ciò che non si può fare in un social network, quello che invece è concesso fare ha come limite non già la fantasia, ma banalmente l’uso intenzionale degli utenti. Sono gli utenti che plasmano LinkedIn come qualsiasi altro network, così come in passato sono stati plasmati i grammofoni, gli orologi, le biciclette e le lampadine (chi non credesse a una simile affermazione può leggere La bicicletta e altre innovazioni di Wiebe Bijker, purtroppo a oggi piuttosto introvabile nella sua versione italiana). Se l’evoluzione di oggetti tecnici fisici è stata oggetto di contrattazione sociale, non è facile comprendere come lo sia quello di un’applicazione web.
Si pensi a Twitter, nel quale l’uso dello hashtag (#) e della chiocciola (@) sono stati introdotti dagli utenti; ancora, da mesi si vocifera di una possibile rimozione del limite dei 140 caratteri, che, immesso agli albori poiché Twitter funzionava attraverso gli SMS, non fu più necessario dopo breve, ma è rimasto come carattere distintivo del microblogging. Dopo che una tecnologia appare sul mercato, non è il produttore a virare, ma gli utenti che la indirizzano verso usi non previsti, a forzarne le modifiche quando uso e struttura divergono troppo.
3) Credo che LinkedIn non si lagni per nulla dell’uso “ampliato” del proprio network. Più aziende bloccano Facebook sui dispositivi connessi nella propria rete, più utenti si rivolgeranno ai social network ancora a disposizione, e normalmente LinkedIn non è bloccato dai firewall. Quindi, aspettiamoci l’invasione dei gattini su LinkedIn. E aspettiamoci una “zona relax”, un “coffee talks”, una “area break” all’interno del network, dove si può per un attimo allentare il nodo della cravatta.
Il preteso mantenimento continuo della professionalità su LinkedIn suona invece come la rimozione della pausa caffè, e diventa arma a doppio taglio per coloro che lo richiedono per il classico argomento della trave e della pagliuzza. Quanti infatti tra gli argomenti considerati “professionali” sono invece banalizzazioni di filosofie più nobili, quante vignette “serie” sono senza particolare utilità e significato, e quanti motti e massime sono in realtà malcelati dettami da macelleria PNL? Non è preferibile qualcuno che rilascia la tensione e ride di gusto per poi tornare a fare le cose seriamente rispetto ad altri che nemmeno quando si concentrano riescono a produrre qualcosa di utile? Il perbenismo spesso mostra poca elasticità mentale.
E poi pensiamoci, se LinkedIn serve a capire che persona è quella che stiamo per assumere, o per proporre per un’assunzione, non è più comodo conoscerla in modo più completo sul solo LinkedIn senza dover per forza scandire le sue gesta su Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Vine, Periscope, YouTube e Gazzetta.it?
P.S.: poi, se come è capitato a me, a richiedere che LinkedIn sia mantenuto professionale è la signorina di cui sotto, mi adeguo volentieri. Con quel calzino può dire ciò che vuole.