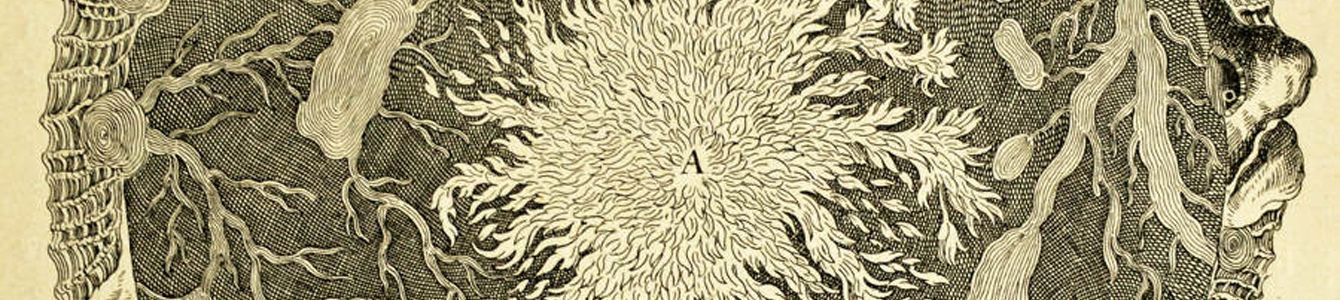Un messaggio sponsorizzato di LinkedIn mi proponeva un corso sulla gestione dell’attenzione e delle priorità. Si tratta di un veloce corso audio, ma dopo aver ascoltato l’estratto di poco più di un minuto ho preferito leggere il libro a firma della stessa docente del corso.
Un messaggio sponsorizzato di LinkedIn mi proponeva un corso sulla gestione dell’attenzione e delle priorità. Si tratta di un veloce corso audio, ma dopo aver ascoltato l’estratto di poco più di un minuto ho preferito leggere il libro a firma della stessa docente del corso.
Partire dalle etimologie quando si inizia uno scritto può sembrare pedissequo o pedante. Quando, come nel caso di Attention Pays di Neen James, un vocabolo come “attention”, il cui campo semantico coincide in modo preciso con “attenzione”, è usato in modo così ampio, per di più con la diffusa aggiunta di un aggettivo come “intentional”, un occhio all’etimo può tuttavia essere d’aiuto.
“Attenzione” ha origine latina, ed è composta dalla particella “ad” (‘a’, ‘verso’) e da “tendere”, (‘distendersi’, e più estensivamente ‘mirare’, ‘aspirare’). Indica un’inclinazione attiva verso qualcuno o qualcosa. Suona quindi sin da subito strano che l’autrice debba introdurre la locuzione “intentional attention”. Buona norma sarebbe stata quella di definire sin da subito il significato di un’espressione apparentemente ridondante, ma la James preferisce trasferirlo a poco a poco con spiegazioni, esempi e schemi.
Peccato che nel libro, sotto il cappello di quell’espressione finisca un’ampia gamma di disposizioni d’animo, che poco e nulla hanno a che fare con l’attenzione, intenzionale o meno. Meglio si direbbe se si parlasse di interesse (pur citato da James), amore, cura, riguardo, affetto, protezione, impegno, sollecitudine, caritas, responsabilità, obbligazione, obbligo, necessità. Perché occorre porre “attenzione” alla strada quando si guida, ma non va confusa con quella per la propria igiene personale, per il pianeta che soffre, per la persona che si ama, per il collega che parla, per il programma televisivo che si segue, per il post su LinkedIn o per il messaggio di posta elettronica in attesa di risposta. Sono in gioco sistemi etici, affettivi, impianti dei doveri e dei diritti, e in definitiva una filosofia che non possono essere mortificati da un simile appiattimento.
Nel rendere pratico il dettame della sua “Attention Revolution” la James si inerpica per ardui sillogismi, e definizioni che suonano piuttosto fesse.
Esempio del primo è la spiegazione sul sistema di attivazione reticolare. Si tratta del sistema che compie la selezione degli stimoli esterni, dando loro gerarchia rispetto a criteri interni, e conseguente attenzione. Se oggi siamo più attenti a Facebook che al viso della persona amata, che cosa significa? Che davvero ci interessa più un post sui gattini o che la nostra attenzione è deviata rispetto a ciò cui dobbiamo dedicare la nostra attenzione? Ovviamente James opta per la seconda opzione, affermando implicitamente come il sistema di attivazione reticolare non stia funzionando, di fondo, in modo corretto. All’autrice non sfiora il dubbio di una dovuta spiegazione in merito, ma lancia subito le tecniche di riprogrammazione, al fine di dare attenzione a ciò che è “giusto”.
In merito alle definizioni, è introdotta una tripartizione di tipologie di attenzione, da utilizzare secondo necessità, senza abusi. La prima è la “strobe light attention”, l’attenzione “a eventi pulsati” utilissima nei brainstorming. Peccato che fosse quella che l’autrice la bollasse come da evitare, poiché apportatrice della modalità di lavoro multitasking. Segue la “flashlight attention”, che guida l’individuo nel buio degli stimoli esterni (in un altro passaggio si parla della condizione dell’uomo corrente come overwhelmed, termine caro a Eco, allo stesso modo in cui uno si trova a Times Square è quasi accecato dai tanti e grandi schermi pubblicitari), ma che se usata senza criterio può portare a cieca obbedienza alla visione di qualcuno. Chiude la “spotlight attention”, che è utile per concentrarsi su di un ambito stretto, ma che impedisce la visione d’insieme se abusata. Come a dire, “state attenti, concentratevi, ma non troppo, perché fate la fine del cavallo con i paraocchi”.
In definitiva, un testo dallo stile molto semplice, direi piatto, che raggiunge il picco dell’utilità quando suggerisce (e lo fa decine di volte, direttamente o indirettamente) di allontanarsi dal proprio telefono cellulare, o almeno di usarlo con oculatezza e misura.
Per il resto, un mare magnum di ovvietà e piccoli trucchi dialettici, all’insegna del “ti ho accalappiato con il titolo, ora sei mio”.
Dovendo scegliere una citazione, a misura della reale attenzione prestata ad alcunché dalla venditrice di un metodo senza basi scientifiche, psicologiche, dignità o utilità: “I am not a card‐carrying member of Greenpeace (but I do love some of the work they do), and I don’t drive a Tesla (although I love them and think they are incredibly sexy cars)”. Ogni commento è superfluo.
Appena oltre questo epitaffio, al termine del capitolo introduttivo, Neen James suggerisce di terminare la lettura qualora non fosse stata in grado di convincere il lettore a farlo. Che qualcuno sia andato oltre, sino a un terzo del testo – come chi scrive, se non fosse chiaro –, già è qualcosa, e mostra come l’attenzione si rivolga spesso a oggetti inutili. Perché costringerla sempre alla produttività?